di Michele Salvati
Un “partito nuovo” non nasce e non sopravvive (di nuovi partiti ne nascono e muoiono a bizzeffe) se non risponde ad una esigenza storica, a una domanda del tempo, che i suoi promotori sono capaci di avvertire anche quando essa non è esplicita. Nasce e sopravvive se vi risponde. Se i suoi promotori riescono a identificare aspirazioni già profondamente sentite di un gran numero di cittadini e a strappare dall’incertezza o dall’incoscienza altre esigenze ancora latenti; se riescono a rendere credibile un’analisi coerente e realistica dei problemi che il Paese affronta; se riescono, soprattutto, a rendere desiderabili soluzioni efficaci a questi problemi. A differenza dell’Angelus novus di Benjamin, un partito nuovo guarda in avanti, non è sospinto dalla bufera mentre tiene il viso rivolto all’indietro. Un Manifesto di fondazione, una Carta dei valori e dei principi, un Programma fondamentale – il nome verrà scelto quando sarà il momento: ora uso il primo- dovrebbe fornire una sintesi efficace di quelle aspirazioni, di quelle analisi, di quelle soluzioni. E’ un biglietto da visita, una carta d’identità, un invito alla mobilitazione, e dev’essere tanto breve quanto lo consentono la chiarezza e l’efficacia retorica. Soprattutto dovrebbe far comprendere perché c’è bisogno del Partito Democratico e gli obiettivi che esso intende perseguire. Non è mio compito o mia intenzione fornire un modello di questo Manifesto. Quello che mi propongo è solo di suggerire a chi dovrà redigerlo qualche tema su cui riflettere, partendo dalla della crisi in cui si trova il nostro Paese per arrivare al contributo che il Partito democratico potrebbe dare per risolverla. In mezzo, altri spunti: sullo stato del sistema politico italiano, sulla sinistra e il centro-sinistra in Europa e in Italia, sul nome che si sta consolidando e fortemente raccomando, “Partito Democratico”, sui valori e sui principi che questo partito dovrebbe sostenere. Si tratta di osservazioni preliminari, semplici avvertenze per coloro che, assumendosene responsabilità politica, dovranno effettivamente stendere una o più bozze di Manifesto.
L’Italia a rischio declino. Primo imperativo: tornare a crescere
Non siamo più in campagna elettorale e la preoccupazione di essere tacciati di Cassandre non dovrebbe indurre gli estensori del Manifesto a cautele diplomatiche: il rischio declino è testimoniato da una massa di indicatori uniformi nel loro messaggio e l’analisi delle sue cause si sta consolidando. In un Manifesto di indicatori se ne devono usare pochi e ben scelti, che mostrino come il problema non riguarda solo l’economia, dov’è evidente, ma l’intera società: l’invecchiamento della popolazione, la scarsa istruzione, la debolezza della ricerca, l’inefficienza di molti servizi collettivi, la tolleranza per l’illegalità, la tendenza a rifugiarsi in difese corporative o in settori di rendita, a difendere con le unghie e coi denti grandi e piccoli privilegi, a evitare quant’è possibile l’apertura alla concorrenza. E delle cause va sottolineata soprattutto la profondità storica, rivolgendosi il Manifesto ad un popolo che tende a far risalire le difficoltà che oggi avverte a tempi molto recenti, se non addirittura a Berlusconi. No, le nostre difficoltà erano già scritte nel fallimento del centrosinistra, nella seconda metà degli anni ’60, e nelle numerose occasioni di riscatto perse dopo di allora. Berlusconi ha avuto il torto di sottovalutarne la gravità, di muovere da un’analisi in larga misura erronea, di non avere attuato il programma di liberalizzazione e concorrenza tous azimuth che pure in parte aveva promesso: dunque di aver contribuito a incancrenire una situazione che, prima veniva affrontata, meglio era. Il nostro è un grande Paese, straordinariamente ricco di risorse. Esso deve tornare a crescere, economicamente e culturalmente: è questo il primo compito che si deve porre il Partito Democratico. Un partito di sinistra non ha il mito della crescita nel suo Dna, quantomeno non della crescita economica di per se stessa. Ma un partito di sinistra riformista si rende conto che, senza crescita, diventa molto più difficile far prevalere i valori, la cultura, gli obiettivi sociali che gli sono più propri. In un’economia di mercato ed in una società in cui i piani di vita sono perseguiti in modo indipendente da milioni di individui, il ristagno comprime le possibilità di mobilità sociale, aumenta e consolida la frazione degli esclusi, diffonde atteggiamenti di preoccupazione e di paura, induce a difendere all’estremo anche i minimi privilegi, corrode i legami di solidarietà. Tornare a crescere, per una società ed una economia che hanno accumulato tante storture, può comportare sforzo, difficoltà e sacrifici. Essi non vanno negati o nascosti. Contrastare anche quelli che sono strettamente necessari per riattivare lo sviluppo è un atteggiamento perdente, non egemonico, improprio per una sinistra di governo: questa deve cercare di ridurre quanto è possibile le difficoltà per le persone con minori risorse, ma non può rinunciare a perseguire le politiche che servono a riavviare la crescita nel contesto nazionale e internazionale in cui effettivamenteci troviamo. Non in altri contesti che ci piacerebbero di più, ma che hanno il piccolo svantaggio di non esistere.
Il sistema partitico italiano: parte del problema, non della soluzione
E’ inevitabile pensare alla politica quando una collettività affronta gravi problemi economici e sociali: da che altra parte può venire la soluzione se non da un indirizzo efficace degli sforzi collettivi? Ma la politica e le istituzioni pubbliche sono un pezzo della società e raramente sono “migliori” di questa: quando una società è in crisi, di solito la politica non è un punto solido sul quale applicare la leva del cambiamento, ma più spesso è un elemento che contribuisce ad aggravare la crisi stessa. Qualche piccolo margine per una buona politica esiste, tuttavia, ed è questa la ragione per cui ci impegniamo nella costruzione del Partito democratico. Ma dobbiamo essere consapevoli che veniamo da una lunga storia, durante la quale la politica è stata quasi sempre un pezzo del problema, non della soluzione. Così è stato per buona parte della Prima Repubblica, specie a partire dalla fine degli anni sessanta del secolo scorso. La peculiarità storica, in un contesto europeo occidentale, di un partito comunista di gran lunga prevalente sul socialista, è stata a suo modo controllata negli effetti più dannosi mediante un’altra peculiarità storica, di origine ancor più lontana: la grande forza di un partito appoggiato dalla Chiesa cattolica. Il programma non può dilungarsi in un’analisi approfondita della Prima Repubblica, ma almeno due punti deve affermarli con chiarezza. Il primo è che i due grandi partiti “peculiari” della Prima repubblica, la Democrazia cristiana e il Pci, erano legati da un vincolo di necessità, di mutua dipendenza, durante i lunghi anni della guerra fredda: solo la Dc era in grado di impedire democraticamente l’accesso del Pci al governo, e dunque gestire in modo civile una impossibilità di alternanza. Il secondo punto è che, finita la fase del centrismo, questo peculiare sistema partitico produce esiti di governo assai scadenti: controlla a mala pena e con grandi costi le tensioni sociali degli anni ’70 ed entra in una fase di consociativismo e collusione alla fine di quel decennio e per tutto il successivo, anche questa con effetti perversi sulla finanza pubblica e ostacolando la costruzione di istituzioni capaci di sostenere lo sviluppo nel lungo periodo. Questi punti vanno affermati con forza perché, anche a seguito delle deludenti prove di Seconda Repubblica che sinora abbiamo avuto, un filo di rimpianto e nostalgia lega non pochi leader del centrosinistra, ancora in servizio permanente effettivo, ai due grandi partiti della Prima. Questo filo va spezzato e bisogna guardare in avanti: alla Prima Repubblica non solo è impossibile tornare, ma è sbagliato sperare di tornarvi, perché essa è all’origine di gran parte dei nostri problemi attuali. Naturalmente l’origine immediata di questi problemi sta nel cattivo funzionamento della Seconda, sta nel bipolarismo esasperato e rissoso in cui siamo caduti dopo la grande crisi politica dei primi anni ’90: una crisi unica in Europa, che vede la distruzione dei due partiti che in molti paesi del nostro continente costituiscono i pilastri di governo e opposizione. Le cose potevano andare diversamente: la Democrazia Cristiana poteva trasformarsi in un grande partito conservatore e moderato, e dalla fusione di socialisti e comunisti (con egemonia culturale dei primi) poteva nascere un grande partito riformista. Ma la storia non segue vie semplici e le peculiarità della Prima Repubblica –la Dc non era tutta un “normale” partito conservatore, i rapporti tesissimi tra comunisti e socialisti impedirono la fusione dei due tronconi del Movimento operaio che si erano separati settant’anni prima, e poi ci si mise di mezzo anche Mani pulite- produssero il risultato che tutti conosciamo: la Lega, la discesa in campo di un imprenditore politico abile e spregiudicato, la diffusione di intense pulsioni populistiche e antipolitiche nel corpo elettorale. Non tutto il male viene per nuocere e un risultato importante è stato raggiunto: per la prima volta nel nostro Paese gli italiani tutti si sono divisi tra una coalizione di governo e una di opposizione, queste si sono di fatto alternate nei due ruoli –in modo rissoso ed esagitato, è vero, ma ben al di sotto della soglia di una guerra civile, anche a bassa intensità- e dunque le premesse elementari di una democrazia piena sono state faticosamente conquistate. Di conseguenza non vediamo altra via per andare avanti se non quella di eliminare dal nostro sistema partitico quei caratteri (“esagitati e rissosi”) che rendono il nostro bipolarismo e le nostre alternanze così diverse da quelle di paesi con una democrazia più matura di quella italiana. Insomma, il compito che abbiamo di fronte è quello di costruire un sistema partitico in cui la destra non si definisca principalmente per essere “berlusconiana” e la sinistra per essere “anti-berlusconiana”, in cui si affievoliscano le lealtà politiche tribali che oggi prevalgono, in cui si formi un numero sufficiente di elettori attenti ai programmi e alle qualità di governo offerte dai due schieramenti, che non avvertano come tradimento passare dall’uno all’altro. Il compito che abbiamo indicato riguarda sia la destra, sia la sinistra, e per entrambe esso comporta la costruzione di due grandi partiti moderati, che siano i perni intorno ai quali si formeranno le due coalizioni di una alternanza civile. Sia a destra che a sinistra la natura e l’urgenza di questo compito sono perfettamente avvertite, proprio come sono avvertite le difficoltà di assolverlo. Per la destra il problema è il passaggio weberiano dal carisma all’istituzione, il superamento dell’eredità berlusconiana. Per la sinistra il problema è la costruzione del Partito Democratico, il superamento di una situazione in cui lo spazio di un grande partito riformista è oggi occupato da due partiti di grandezza media e medio-piccola, o da altri di stazza ancor minore. Partiti che hanno tutti le loro buone ragioni storiche, dovute al trascinamento di lealtà, ideologie e consuetudini che si erano formate, e avevano senso, nella Prima Repubblica. Nella Seconda esse hanno un senso assai minore e al più giustificano la formazione di orientamenti blandamente organizzati all’interno di un unico partito, come del resto avviene in tutti i grandi partiti riformisti (e conservatori) europei. Lasciamo ovviamente alla Destra il compito della costruzione del partito post-berlusconiano, ribadendo che esso è almeno altrettanto difficile, urgente e necessario di quello che deve affrontare la Sinistra. Ora è il momento di passare alle ragioni del Partito democratico.
La sinistra riformista europea e mondiale
Prendiamo le cose un po’ alla lontana, dando un’occhiata al campo internazionale, e soprattutto europeo, in cui il Partito democratico dovrà inserirsi. Rispetto all’“età dell’oro” –durata circa trent’anni anni, iniziando subito dopo la fine della seconda guerra mondiale- gli anni ’80 segnano un passaggio importante, storico e ideologico. Nell’età dell’oro la sinistra europea è quasi ovunque riformista e socialdemocratica, schierata con le democrazie occidentali nel grande scontro col comunismo. Quasi ovunque, tacitamente o con aperte revisioni programmatiche, il socialismo si sbarazza dei più ingombranti residui del programma massimo –il “superamento del capitalismo”- che le socialdemocrazie tra le due guerre ancora condividevano e si pone obiettivi pienamente compatibili con un’economia di mercato e un sistema sociale capitalistico. Di fatto, saranno due grandi liberali, Keynes e Beveridge, a fornire alle socialdemocrazie europee gli obiettivi e gli strumenti che garantiranno loro uno straordinario successo, sia come forze di governo che d’opposizione. E saranno le istituzioni internazionali disegnate dalle potenze vincitrici e il regime di politica economica sostenuto dagli Stati Uniti sino alla fine degli anni ’70 a creare le condizioni di contesto in cui gli obiettivi di piena occupazione e di welfare state potranno essere raggiunti senza soverchie tensioni. Tutto questo cambia al volgere degli anni ’70 negli ’80 e ancor più dopo l’89, dopo la fine della minaccia comunista. Sarebbe istruttivo spiegare perché il regime internazionale di Bretton Woods è crollato, perché la formidabile iniziativa politica e culturale delle destre, di Thatcher e Reagan, ha avuto successo e perché le sinistre riformiste non sono state in grado di contrastarla. Il Manifesto dovrà probabilmente limitarsi a riconoscere che il mondo è cambiato dopo di allora. Che gli obiettivi che una sinistra riformista può porsi in un paese avanzato ma di piccola stazza com’è il nostro -rimanendo per ora lontana la prospettiva di un’Unione Europea come un reale soggetto politico unitario, almeno in materie come politica estera e difesa- sono diversi da quelli dell’età dell’oro. Che strumenti come quelli di deregolazione, privatizzazione, liberalizzazione, concorrenza, competitività, flessibilità, adattamento strutturale sono ormai parte della scatola degli attrezzi della sinistra, se questa vuole essere forza di governo. Guardiamoci intorno: quasi ovunque le sinistre riformiste hanno cambiato strategia. Qualcuno dirà: si sono adattate alla situazione e hanno ridimensionato i loro obiettivi. E’ senz’altro così, ma non è solo così. Affrontare un nemico ideologicamente agguerrito, non più succube di quella koiné statalista, assistenzialista e keynesiana che nell’età dell’oro condividevano tutti, sia conservatori che riformisti, ha indotto le sinistre riformiste ad abbandonare residui ideologici che si trascinavano appresso per pigrizia, a confrontarsi seriamente col pensiero liberale, a riscoprire in esso ragioni che la sinistra poteva far proprie. La grande novità di questi ultimi dieci anni è proprio la sinistra liberale e l’abbandono, non più opportunistico, ma consapevole e di principio, degli ultimi residui classisti della tradizione del movimento operaio anche da parte di partiti che ancora si chiamano socialisti, laburisti o socialdemocratici. Blair, Schroeder, Zapatero non sono socialdemocratici in alcun significato storicamente e ideologicamente preciso del termine: sono dei liberali di sinistra. E i riferimenti culturali e ideologici loro e dei loro partiti sono Sen, Rawls, Dworkin, Bobbio, Walzer -per menzionare solo i più noti in Italia-, teorici tra loro assai diversi ma tutti iscrivibili nella grande tradizione liberale. L’eccezione più importante è costituita dal Partito socialista d’oltralpe, per il quale la parola liberal quasi equivale a un insulto: ma questo ha a che fare più con l’eccezionalismo culturale dei francesi che con vere differenze di strategia politica. Insistiamo su questa novità, sulla critica e l’abbandono dei residui classisti e marxisti nella sinistra d’origine socialdemocratica, perché questo ritorno alle origini prepara un terreno d’incontro favorevole con altri filoni della sinistra riformista, minoritari di solito, ma in alcuni paesi assai importanti. Alcuni di essi –repubblicani, liberali, ambientalisti- il terreno liberale non l’avevano mai abbandonato. Altri –ci riferiamo ai riformismi con forti connotazioni religiose, e soprattutto a quelli ispirati alle dottrine sociali della Chiesa cattolica- perché con il liberalismo si erano da tempo parzialmente riconciliati. Insomma, dal punto di vista delle radici culturali profonde nulla osta ad una fusione politica di correnti riformistiche che in passato si erano divise, o addirittura combattute.
Il peso del passato: tre trappole da evitare…
La prima trappola l’abbiamo appena menzionata, parlando di fusione dei diversi riformismi. Guai se ai lettori del Manifesto resterà in mente che la principale giustificazione del Partito Democratico è la “fusione” (o, ancor peggio, la “contaminazione”) dei diversi filoni del riformismo italiano. La possibilità di fusione, la presenza di un ampio terreno liberale comune, la condivisione di pezzi significativi di diverse tradizioni, sono cose assai importanti, specie per le élites politiche e i militanti dei partiti, che in queste diverse tradizioni sono stati allevati. (Lo è assai meno per la gran massa dei cittadini, anche per i segmenti più colti e appassionati di politica). Ma basta un momento di riflessione per rendersi conto che si tratta di una condizione non ostativa, di una condizione permissiva: non si tratta della ragione profonda, della ragione storica, che ci induce a metterci insieme per costruire il Partito democratico. Essa ci dice che dal passato non vengono impedimenti insuperabili, vuoi perché alcune delle tradizioni e lealtà che nel passato erano vitali hanno esaurito la loro funzione storica; vuoi perché, se ciò non è vero, esse possono continuare a svolgerla nel nuovo partito. Ma non ci dice niente del futuro. Limitarsi alla fusione/contaminazione è come identificarsi coll’Angelus Novus: travolti in avanti, colla faccia rivolta all’indietro. Negli anni scorsi, in molti appelli per l’Ulivo e il Partito Democratico, abbiamo insistito molto, forse troppo, sul problema della compatibilità dei riformismi del passato. Ma ci rivolgevamo al ceto politico. Con il Programma ci rivolgiamo al Paese, e al Paese bisogna parlare di futuro. Il passato pesa, però, e si manifesta in molti modi. Uno dei modi, ed è la nostra seconda trappola, riguarda la continua incertezza sullo spazio politico del partito democratico: sinistra o centrosinistra? Se chi insiste sul termine centrosinistra vuol solo segnalare che la componente maggioritaria del nuovo partito persegue un disegno politico riformistico-liberale, non dissimile da quelli di Blair o di Schroeder (o di Zapatero, se lo si studia bene); se vuole segnalare che nel suo nucleo devono essere presenti i valori e le culture del riformismo cattolico o di altri riformismi moderati del centrosinistra; se è solo per questo, allora può benissimo rassegnarsi a parlare di sinistra. E’ questo che avviene nei paesi in cui si è solidamente istallato un sistema politico bipartitico o bipolare, dove non ha senso parlare di centro. Si tratterà ovviamente di una sinistra moderata e spesso avverrà che tra le componenti maggioritarie di sinistra e destra ci sia più consonanza che con i piccoli partiti estremi che hanno assemblato nelle loro coalizioni. Anche un bambino sa, tuttavia, che non sono questi i motivi per cui alcuni esponenti di Margherita insistono tanto sull’espressione “centrosinistra”. I motivi sono altri: in parte è l’affezione per il centrismo della vecchia casa democristiana; in parte è il legittimo orgoglio per aver tenuto ferma la barra del timone su alcuni temi cruciali di politica economica e di politica culturale, dal rifiuto del collateralismo con organizzazioni economiche e sindacali ad una posizione laica ma non laicista; in parte è il timore di un ceto politico di farsi fagocitare da un ceto politico più forte; in parte, e forse si tratta della parte maggiore, è l’indisponibilità a confluire, in Europa, in un partito socialista ancora troppo affezionato alle proprie tradizioni, anche se di fatto ha cambiato pelle. Si tratta di motivi di resistenza, tutti, più che legittimi, e ai quali dev’essere data una risposta più che generosa. Alle soglie della costruzione del nuovo partito, tuttavia, insistere troppo su un’espressione che non ha senso in un sistema politico bipolare può essere fonte di confusione: non è il bipolarismo, un bipolarismo civile, uno dei principali obiettivi politici del nuovo partito? Parlando di centro, si vuole forse lasciare aperta la strada per uscire dal bipolarismo? Proprio perché uno schieramento di sinistra moderata può affrontare momenti eccezionali, in cui per il paese possono essere indispensabili governi tecnici o di grande coalizione –ciò è appena accaduto in Germania- non deve esserci dubbio alcuno che l’orientamento di fondo di tutte le componenti del partito è uno di sinistra: moderata quanto si vuole, ma iscritta fermamente in una logica bipolare. Crediamo dunque che sarebbe opportuno che queste incertezza venissero dissipate il più rapidamente possibile. Così come deve sparire al più presto ogni incertezza sul nome del partito, e qui ci rivolgiamo ai Ds, come prima ci eravamo rivolti a Margherita: è la nostra terza trappola che proviene dal passato. Che cos’è questa continua riproposizione del nome “Partito Riformista”? Il nome “riformismo”, e il suo aggettivo, o non hanno alcun significato discriminante, o ne hanno uno del tutto improprio. Ogni partito, di destra, sinistra o centro, propone riforme, riforme diverse naturalmente: neppure i conservatori più incalliti hanno il coraggio di sostenere che intendono lasciare le cose esattamente come stanno. Dunque “riformismo” non vuol dir nulla. Voleva invece dire una cosa ben precisa nella lunga vicenda storica del Socialismo, dove “riformista” si opponeva a “rivoluzionario” e in quella vicenda ha avuto almeno due versioni: chi la rivoluzione non voleva farla adesso ma riconosceva di doverla fare in un (più o meno lontano) futuro o in circostanze che la rendessero inevitabile; e chi la rivoluzione non voleva farla mai. Donde contorsioni patetiche: chi non ricorda la riluttanza del Pci, fino a tempi piuttosto recenti, a definirsi come partito riformista preferendo il termine –del tutto identico- di riformatore? Ma chi vuol farci ripiombare in questa vecchia storia? Dunque, Partito Democratico. Non perché è il nome di un grande partito americano. Ma perché ha un significato profondo, chiarissimo, sempre attuale e incarna alla perfezione le ragioni per cui vogliamo costruire un nuovo grande partito.
…e un valore da esaltare: la democrazia.
La democrazia è un compito mai finito e anche i regimi più “democratici” che oggi conosciamo sono ben lontani dall’ideale: un ideale di cittadini colti e informati, in condizioni di buona sicurezza economica e dunque con il tempo necessario da dedicare alla politica, che confrontano un potere pubblico trasparente e media indipendenti e molteplici, che dibattono seriamente una pluralità di opinioni e dispongono di molti strumenti per controllare l’esercizio dei poteri di rappresentanza, e soprattutto dei poteri di nomina che i rappresentanti hanno e di cui spesso abusano. Non è un obiettivo abbastanza di sinistra? Lo è, e sarebbe addirittura un obiettivo rivoluzionario, se si volesse raggiungere subito l’ideale cui abbiamo accennato: meno male che c’è un pizzico di cautela e riformismo (nel senso di “migliorismo”) a trattenerci! Scherziamo, ma solo per rendere più evidente l’idea che nel nome di democrazia c’è già dentro tutto quanto possiamo desiderare. Ma se la democrazia è il nostro valore politico essenziale, bisogna essere consapevoli che esso dev’essere praticato cominciando da casa nostra, dal nostro partito. Sia il processo attraverso il quale si costituirà il Partito Democratico, sia lo statuto del partito, devono essere coerenti con un disegno di massima partecipazione e di controllo democratico sulle decisioni di chi ci rappresenta: l’insistenza sulle primarie laddove sono praticabili, la trasparenza massima richiesta nei processi di nomina che i nostri politici controllano, sono solo due aspetti della vera rivoluzione democratica che siamo chiamati a realizzare. Sarebbe tragico –più che un crimine, un errore- se il Partito democratico che vogliamo costruire lo costruissimo con i metodi e lo gestissimo con gli statuti antidemocratici (di fatto, se non sulla carta) dei partiti che conosciamo. E la pratica che intendiamo attuare a casa nostra dev’essere conforme con le proposte che facciamo per riorganizzare il sistema politico del nostro Paese, dalle leggi elettorali alla riforma costituzionale. Uno scandalo antidemocratico come quello che è conseguito alla legge elettorale attualmente in vigore, con candidature totalmente delegate a ristrette oligarchie -chiamarle partiti è un offesa a questo nome glorioso- non deve più ripetersi: che si debba tornare a un sistema elettorale uninominale, e con candidature scelte attraverso primarie, è la proposta minima sulla quale il nostro partito deve spendere le sue energie. Come dovrà spenderle nel proseguire un processo di riforma costituzionale dopo la schiacciante vittoria dei No nel referendum di domenica e lunedì scorsi. Nel centro-sinistra sta diffondendosi una reazione conservatrice (come se il popolo avesse detto No a qualsiasi proposta di riforma), una tendenza ostile ad una democrazia governante a livello nazionale e al suo radicamento in efficienti istituzioni regionali e locali. Credo che il Manifesto debba opporsi esplicitamente a queste tendenze e reazioni. Può un programma liberale di sinistra essere entusiasmante? Ricapitolo in breve i quattro obiettivi che ho sinora attribuito al Partito Democratico. Il primo è quello della riattivazione di un vigoroso processo di crescita. Il secondo è quello di contribuire, insieme ad un analogo sforzo del Centrodestra, a indirizzare il processo di transizione verso un sistema politico bipolare “civile”. Il terzo è quello di attenuare quei caratteri antichi del nostro State and Nation building che oggi ostacolano la costruzione di un moderno partito di sinistra riformista: le eredità di Porta Pia e del Comunismo, se vogliamo identificarli in modo sommario. Il quarto è quello di derivare dal grande valore della democrazia un insieme di implicazioni programmatiche forti. Se i cittadini e gli elettori fossero tutti degli economisti, degli storici, degli scienziati politici, e se tutti fossero uomini e donne di centrosinistra che hanno partecipato attivamente alle vicende politiche del nostro Paese almeno a partire dalla transizione tra la prima e le seconda Repubblica, questo potrebbe già sembrare loro un programma affascinante e ambizioso. Siccome non lo sono, siccome dobbiamo rivolgerci ai giovani e a persone con scarsa esperienza politica, un Manifesto che si limitasse a questi obiettivi dice loro assai poco. Che cosa vuol dire, in Italia ed oggi, essere dei liberali di sinistra? Quali ideali di convivenza civile si sostengono? Quali interessi si promuovono? Qual è la visione del futuro che il nuovo partito prospetta al Paese? Perché il Partito Democratico si propone come forza indispensabile per lo sviluppo del nostro paese e per un suo maggiore apprezzamento nella comunità europea e internazionale? Le vere difficoltà del nostro Manifesto hanno tre origini principali. In parte esse derivano dal divario di sviluppo, interessi, mentalità e culture presente in Italia, dall’esistenza di un “problema del Nord” e di un “problema del Sud”. In parte derivano dalle diverse sensibilità che ci trasciniamo dal passato e dunque dalle mediazioni che tra di esse si riterrà di dover compiere. In parte assai maggiore sono esattamente le stesse che incontrano tutte le forze di sinistra riformista in Europa nel costruire e “vendere” un prodotto appetibile a cittadini che guardano con scarso interesse, in modo saltuario, e quasi sempre con sospetto, alla politica e ai politici. Che volentieri ascoltano un discorso di diritti, ma molto malvolentieri uno di doveri. Che sentono predicare flessibilità “in basso”, e vedono rendite, inefficienza, profitti pingui, compensi scandalosi e scarsissima flessibilità “in alto”. Brevemente sulla prima fonte di difficoltà. Il “divario” cui facevamo riferimento più sopra si è tradizionalmente presentato, nei vecchi programmi dei partiti, con le forme della “questione meridionale”, alla quale tutti promettevano una soluzione: una forte solidarietà nazionale era data per scontata in via di principio e solo si trattava di mobilitarla nei modi più appropriati. Oggi è chiaro che scontata non è. Che trasferimenti e politiche speciali per il Mezzogiorno vanno giustificati di fronte ad una popolazione del Nord più scettica e attenta. E soprattutto è emersa, specie per i partiti della sinistra, una vera e propria “questione settentrionale”: uno scollamento tra valori, orientamenti e programmi di quei partiti e gli interessi, le aspirazioni, la mentalità di larghi segmenti delle popolazioni del Nord, che la destra sembra intercettare meglio della sinistra. In specie se, nel processo costituente e poi nello statuto del nuovo partito, si intende “partire dal basso”, dai territori, e poi organizzare il partito in modo federale, con una significativa autonomia delle diverse realtà locali, si pone un problema non piccolo di sintesi politica, perché gli orientamenti di fondo del “Partito democratico del Nord” possono differire significativamente da quelli del “Partito del Sud”. Una sintesi che era di gran lunga più facile per i grandi partiti della Prima Repubblica, imbevuti di statalismo sia a destra che a sinistra, e in presenza di una popolazione settentrionale non ancora mobilitata dalle Leghe e dalla crisi politica degli anni ’90 e oggi preoccupata dalle difficoltà economiche che incontra il tessuto di micro-imprese sul quale ha costruito le sue fortune. Passiamo alla seconda fonte di difficoltà, le diverse sensibilità politiche provenienti dal passato e rappresentate soprattutto dai partiti che dovrebbero fondersi nel Partito Democratico. Senza sottovalutare i problemi derivanti da interpretazioni più moderate o più radicali di riformismo, le difficoltà maggiori per il nostro progetto politico sono quelle che derivano dalla “questione della laicità”: divisioni e dissensi con la sinistra radicale possono essere tollerati, una rottura grave con il riformismo d’origine cattolica mina il progetto alla sua base. Di conseguenza, grande dev’essere l’attenzione dedicata ai temi “eticamente sensibili”, com’è invalso chiamarli oggi: quei temi sui quali la Chiesa cattolica (o le chiese e le religioni in generale) impongono ai fedeli prescrizioni assolute, che gli agnostici (o i seguaci di religioni diverse, o in pratica gli stessi fedeli della chiesa o religione che le impone) non intendono ottemperare. La rilevanza politica di questi temi è in parte il frutto di sviluppi scientifici e culturali intensi e talora traumatici, che attraversano molte società avanzate contemporanee. In parte ancor maggiore, e non solo nel nostro paese, è il frutto di un uso strumentale provocato da motivi di convenienza politica: la ricerca di nicchie elettorali composte da fedeli intransigenti, come negli Stati Uniti, o dell’appoggio delle gerarchie ecclesiastiche, come in Italia. Questa seconda parte dovrebbe perdere d’importanza una volta che i soggetti politici i quali, nel centrosinistra possono avvantaggiarsi di temi eticamente sensibili a scopo strumentale, saranno confluiti in un unico partito. La prima parte resta, e una ragionevole soluzione dei conflitti che può provocare è anzi una delle condizioni affinché tale confluenza possa avvenire. Personalmente sono convinto che questa “ragionevole soluzione” sia possibile, e di fatto la gran parte dei partiti dell’occidente raccolgono sotto un’unica bandiera politica persone intensamente religiose (e di varie religioni) insieme ad atei ed agnostici. Ma non è facile. Non è facile per motivi nobili, perché una rigida separazione tra l’assolutismo delle credenze religiose e il relativismo di quelle politiche è difficile in via di principio, e forse neppure desiderabile. E non lo è, in Italia, per ragioni meno nobili, per la disponibilità della destra ad accettare qualsiasi indicazione delle gerarchie ecclesiastiche e la tendenza di parte della sinistra a competere in questa gara, a non porre con chiarezza una soglia accettabile di laicità della politica (…a me basterebbe che fosse quella che poneva Alcide De Gasperi!). Di qui la necessità e l’urgenza di un approfondimento, gli esiti del quale dovranno essere sinteticamente riassunti nel Manifesto. Dicevo più sopra che le difficoltà maggiori hanno una terza origine, che è comune a tutti i programmi riformisti. Esse derivano dal fatto che il prodotto elettorale che una sinistra moderata può fabbricare e poi cercare di “vendere” non è un prodotto facile. E’ un prodotto che può prevalere sugli altri se i compratori adottano discernimento e giudizio. Che parla al cuore e alla pancia, alle emozioni e agli interessi; ma anche, e in misura notevole, alla testa. Che si rivolge a persone consapevoli di propri interessi immediati, certo, ma non insensibili a quelli dei loro concittadini. A persone, per intenderci, che quando si promette loro una riduzione delle tasse, sono sì soddisfatte, ma subito si chiedono quali saranno le spese e i servizi pubblici che verranno eliminati, e per chi. Ogni paese, e dunque ogni sinistra riformista, ha difficoltà e occasioni particolari: ma il problema che tutte le sinistre riformistiche e moderate incontrano nel sollecitare partecipazione ed entusiasmo su un programma inevitabilmente “ragionevole”, universalistico e altruistico, che non può avvalersi di slogan estremistici e populistici senza snaturare il suo messaggio,… questo problema è proprio lo stesso. In un grande paese europeo solo un partito e un leader –il Labour e Tony Blair- sono riusciti a indovinare un messaggio che ha incontrato un durevole successo presso gli elettori. Ci sono riusciti (oggi sarebbe forse più appropriato dire: ci erano riusciti, perché il consenso sembra si stia erodendo) in parte per la loro effettiva capacità di innovazione politica, in parte per il forfait degli avversari, in parte per le massicce e indovinate dosi di retorica e di spin che hanno/avevano adottato. Il modello britannico è però difficilmente trasferibile: il liberalismo ha radici profonde in quel paese e quattro legislature conservatrici di fila, da un lato l’avevano fatto riemergere con piena forza, dall’altro avevano suscitato una grande domanda di cambiamento nella continuità. Tutto è più difficile per noi e non basta tradurre superficialmente in italiano la Terza Via: temi, argomenti, retorica dovranno essere parzialmente diversi e profondamente italiani. E c’è un altro pericolo da evitare, forse maggiore che non l’imitazione pedissequa del modello britannico: la ricaduta in un modello italiano che ha già ampiamente provato la sua scarsa capacità di attrazione, il modello azionista. Questo modello si propone spontaneamente perché è l’unica esperienza effettiva di liberal-socialismo che il nostro Paese ha conosciuto e perché è stato sostenuto da grandi italiani, da persone che tutti abbiamo ammirato e amato. Ma, sia nella sua versione originale, sia e soprattutto negli emuli di oggi, si tratta di un modello inadatto a un grande partito. Ci vuole più liberalismo in Italia. Ci vuole maggiore rispetto per la legalità. Ci vuole più civiltà. D’accordo. Ma chi combatte per questi obiettivi non deve mai dare l’impressione di mettersi al di fuori della storia del Paese, di ignorare i successi che esso ha ottenuto, di misconoscere i meriti che i grandi partiti e le culture politiche di massa della Prima repubblica -sì, ci riferiamo proprio a democristiani, comunisti e socialisti, con tutti i loro difetti- hanno acquisito in difficili circostanze storiche. Insieme a quegli obiettivi di civiltà, i leader del nuovo partito devono proporne altri che possano essere sentiti come propri da gran parte dei cittadini e non solo da minoranze altamente istruite, benestanti e cosmopolite. Non devono essere e sembrare arroganti, giacobini e anti-italiani: si deve capire che la critica a come le cose stanno e le proposte di riforma vengono da un partito che è un pezzo di popolo e condivide un orgoglio nazionale profondo. Dicevamo prima che una traduzione letterale del messaggio di Blair è priva di senso. Ha però molto senso tradurre uno dei pezzi portanti della sua retorica: il suo nazionalismo vero e democratico, l’elogio di una “britishness” (di una “italianità”, per noi) declinata in modo civile e progressista.
E allora?
Gli “spunti per il Manifesto” che intendevo proporre sul il ruolo storico che il Partito Democratico può assolvere, sulle cautele e le precauzioni da adottare nello stendere il documento di fondazione, più o meno sono questi. Entrare nel merito, lanciare alcuni messaggi caratterizzanti sui valori e i principi che sosteniamo e sull’Italia che vogliamo, come non era mia intenzione, così non è mio compito. Se il Partito Democratico nascerà attraverso un processo costituente…democratico, ovviamente di bozze di Manifesto ce ne saranno più d’una, perché, anche se questi “spunti” sono condivisi, essi lasciano spazio ad una grande varietà di stesure, significativamente diverse l’una dall’altra. Democrazia significa (anche, e per molti soprattutto) competizione: come può avvenire una competizione onesta tra potenziali leader se non c’è competizione tra programmi? Su quale base razionale possono scegliere il potenziale leader, e prima ancora i loro rappresentanti all’assemblea costituente, quei cittadini che vogliono partecipare al processo di costruzione del nuovo partito? Possono forse scegliere il leader, e sto scherzando, perché uno è nu bello guaglione, l’altro altissimo e sottile, il terzo un sindaco di successo, il quarto…? All’interno di coloro che si dicono favorevoli al Partito Democratico molti lamentano che nessuno metta nero su bianco una bozza di programma, che il discorso sui contenitori sia continuamente anteposto a quello sui contenuti. Tra chi esprime questa lamentela alcuni sono sinceri: vogliono il Partito Democratico, credono che si possa fare e desidererebbero una discussione seria sugli orientamenti di fondo del partito cui intendono partecipare. Altri sono un po’ meno sinceri e si lamentano nello spirito in cui ci lamentava della stessa cosa a proposito dell’Ulivo, tra il 2002 e il 2004: in realtà non vogliono che il Partito si faccia, o si faccia in tempi calcolabili; e pensano che, se si discutesse di contenuti, il progetto esploderebbe e forse sarebbe meglio così. Prendiamo sul serio chi si lamenta sinceramente. Hanno ragione. Ma, si tratti di partiti, di associazioni, di gruppi di cittadini interessati, perché non provano loro stessi a stendere una bozza di Manifesto? Non è impossibile e i materiali ci sono tutti: scrivendo questi “spunti” mi sono limitato a questioni preliminari, ma non avrei avuto grandi difficoltà a descrivere nel merito il profilo del partito che mi piace. Ed è vero che ancora non sappiamo come si svilupperà il percorso costituente. Ma non c’è bisogno di saperlo per accingersi al lavoro. Costruire il Partito democratico è un compito difficile, ma non impossibile, se c’è buona fede e coraggio in coloro che dicono di volerlo costruire. Ci sono milioni e milioni di italiani, stanchi di risse e faziosità, indifferenti a distinzioni del passato, preoccupati per il destino del paese e dei loro figli, che sarebbero sensibili al messaggio lanciato dal nuovo partito: il realismo, la serietà, il sentimento nazionale, se accompagnati da un profondo senso di giustizia sociale, da un contrasto tenace dei privilegi, da leggi giuste applicate inflessibilmente e a tutti, sono caratteri apprezzati da un gran numero di cittadini. Trasformare questo potenziale apprezzamento in entusiasmo è poi compito di una leadership carismatica e coesa, di buona organizzazione, di capacità di coinvolgere chiunque voglia partecipare e, perché no, di un po’ di spin bene azzeccato.
da Il Riformista, 2 luglio 2006






 Perchè spesso la
Perchè spesso la  22 parole per un linguaggio nuovo della politica.
Clicca
22 parole per un linguaggio nuovo della politica.
Clicca 








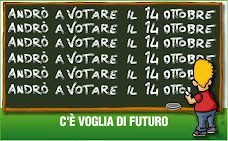


Nessun commento:
Posta un commento