di Alfredo Reichlin
La novità e l'importanza di ciò che è avvenuto con la discesa in campo di Walter Veltroni consiste essenzialmente -mi pare- nel fatto che la costruzione di un partito davvero nuovo (cioè diverso da quelli attuali) ha compiuto un passo avanti serio. Non siamo più alla sommatoria di vecchi ceti politici. Veltroni ha cominciato a definire la fisionomia del nuovo partito. Una forza che si candida a governare una società moderna molto complessa e frammentata come quella italiana uscendo dai vecchi schemi dentro e indicando le condizioni possibili perché questo paese possa ricominciare a «stare insieme». Non c'entrano niente i buoni sentimenti. C'entra la consapevolezza di quali sfide stanno davanti alla nostra patria, e quindi, della necessità di un nuovo patto di cittadinanza. Un patto «inclusivo» non solo tra generazioni e interessi diversi ma tale da far fronte a quella sorta di «secessione silenziosa» del Nord dal Mezzogiorno che si finge di non vedere. Veltroni non si è nascosto affatto la gravità della crisi e la drammaticità dei problemi irrisolti. È in risposta ad essi che ha delineato una idea del futuro del paese che non è astratto perché è sorretta dalle costruzione di una nuova soggettività politica e culturale: quel tipo di forza che qualcuno di noi si era azzardato (da tempo) a chiamare «un partito nazionale».
Perchè così - e solo così - si giustifica la nascita di un nuovo partito all'interno del quale la sinistra non cancelli la sua grande storia. Una forza nuova per una situazione storica nuova. Così come accadde, del resto, con la nascita dei partiti operai al passaggio dall'agricoltura all'industria oppure come si rispose al tramonto dell'età liberale e all'avvento della società di massa: da sinistra con Roosevelt e la socialdemocrazia e da destra con un partito totalitario di massa.
Insomma, io penso questo. E qui sta la ragione del mio giudizio così positivo su ciò che è avvenuto a Torino. Ma è proprio questo evento, proprio per il suo essere così carico di nuovi sviluppi e nuove aspettative, che non chiude ma apre nuove riflessioni. Esso chiama le culture politiche (a cominciare da quella da cui vengo) a confrontarsi non solo con le persone ma con la sostanza della crisi italiana, che è non solo economica e sociale ma si configura ormai come crisi della democrazia repubblicana. C'è, infatti, una ragione se la costruzione di un partito democratico è una impresa così difficile e niente affatto moderata. La ragione è che si scontra con forze molto potenti. Pietro Scoppola ha ragione quando ci invita a chiederci se (cito) «nella storia del paese non ci siano motivi profondi di resistenza se non di incompatibilità rispetto al progetto del partito democratico». E risponde che la formula dei «riformismi che si incontrano» è superficiale perché non dà conto del problema di fondo, tuttora irrisolto, che è la sostanziale incompiutezza (cito ancora) «del processo fondativo della democrazia nel nostro paese. Perché l'amara novità è questa: quel processo, del quale sono state poste le promesse con la Costituzione, non è stato compiuto né a livello etico, né a livello di cittadinanza; né a livello istituzionale».
È evidente. Qui sta la missione del partito democratico. Una missione difficile sia per le ragioni accennate e che stanno dentro la storia italiana, ma che è resa più difficile per l'impatto che il processo reale della globalizzazione sta avendo su un sistema politico debole come quello italiano. È di questo che si parla troppo poco. E io continuo a stupirmi quando leggo che anche uomini di grande intelligenza sostengono che il problema del partito democratico consiste essenzialmente nella scelta tra i fautori del mercato (il filone liberal) e i fautori del vecchio intervento statale (il filone socialdemocratico). Ma dove vivono?
È perfino ovvio e in sé non è affatto un male, (anzi, in sé, è un portato del progresso) il fatto che nel mondo globale lo Stato ha perso la sovranità assoluta e che quindi non è più il solo garante della vita sociale politica e culturale di un popolo-nazione. Ma il grande problema è che questo vuoto non è stato riempito. E non è stato riempito non perché i politici si intromettono troppo nelle «logiche» di mercato ma perché lo Stato ha perso anche il monopolio della politica. Non è poco. Significa che non è più lui il garante della sovranità popolare cioè dei diritti uguali di cittadinanza. E ciò perché sono entrati sulla scena (come sappiamo) altri poteri molto potenti, non solo economici e finanziari, ma anche scientifici, mediatici, culturali. Io non apprezzo affatto, e tanto meno giustifico le derive oligarchiche e autoreferenziali della politica, ma credo che dopotutto sta anche qui la ragione della sua crisi così profonda. Più la politica conta meno nel senso che non è in grado di prendere le «grandi decisioni», quelle che riguardano il destino della «polis», più la politica si attacca al sottopotere e al sottogoverno. E così la democrazia si svuota e aumenta il distacco dalla gente. E si crea quel circolo vizioso per cui a una elites auto referenziale e poco rappresentativa si contrappone una società che si frantuma e si ribella al comando politico.
Se questa analisi è corretta anche quei miei amici che rappresentano il filone «liberal» dovrebbero cominciare a pensare che la vecchia dicotomia tra Stato e mercato non ha più il significato di una volta. La socialdemocrazia non c'entra. È del tutto evidente (come è stato detto e stradetto) che lo squilibrio crescente tra il «cosmopolitismo» dell'economia e il «localismo» della politica ha travolto le basi del vecchio compromesso socialdemocratico. Ed è anche vero che il neo-liberismo non solo ha vinto, ha stravinto ed è diventato da anni la ideologia dominante. Ma posso cominciare a chiedermi se le cose, le cose del mondo nuovo, lo strapotere della finanza mondiale, il sommarsi di ingiustizie abissali con la formazione di una nuova oligarchia straricca, posso cominciare a ragionare senza tabù anche sul rapporto tra mercato e sfera pubblica e sociale? Attenzione, non sul mercato come strumento essenziale dello scambio economico, evidentemente, ma come pretesa di essere il presupposto di ogni sistema sociale e di rappresentare la risposta ai bisogni di senso, di nuove ragioni dello stare insieme a fronte del venir meno delle vecchie appartenenze Veltroni ha ragione nel sottolineare la necessità di creare nuove risorse se vogliamo produrre servizi e capitali sociale (la vera povertà italiana). E queste risorse non le produce lo Stato. Per cui diventa sacrosanto tutto il discorso contro le rendite, i parassitismi, i protezionismi, ecc. E quello sulle liberalizzazioni. Ma Veltroni ha collocato queste affermazioni in un quadro molto più ampio e molto più moderno. Ha reso evidente che se la crescita non si accompagna alla creazione di nuove istituzioni (politiche, sociali, nuove relazioni sociali, capitale sociale) capaci di consentire a una società di individui di diventare cittadini, persone, cioè non solo consumatori ma creatori di se stessi, capaci di esprimere nuove capacità, noi non riusciremo mai a evitare le nuove emarginazione e le nuove miserie. Così la società si disgrega. I dati sull'apprendimento scolastico al Nord e al Sud sono impressionanti. Non è questione di soldi. I soldi ci sono. Mancano fattori sociali e culturali (le cose che fanno diversa l'Emilia dalla Calabria) che non possiamo affidare alle sole logiche di mercato.
Spero che si capirà il senso di queste mie osservazioni. Esse nascono dall'assillo di chi da tempo è dominato dalla necessità di uscire da vecchie visioni, e pensa che il problema di una nuova politica economica è creare un circolo virtuoso tra crescita e coesione sociale, tra politica ed economia. Abbiamo bisogno di un nuovo pensiero e una rivoluzione culturale. E torna in me, vecchio comunista italiano, il senso profondo della eresia gramsciana, l'idea della rivoluzione italiana intesa prima di tutto come rivoluzione intellettuale e morale. Io sogno un nuovo partito il quale faccia leva con più decisione di quanto non abbia fatto la vecchia sinistra classista sul fatto che l'avvento della cosiddetta economia post-industriale e della società dell'informazione richiede e, al tempo stesso, esalta risorse di tipo nuovo, non solo materiali: risorse umane, saper fare, cultura, creatività, senza di che la tecnologia non serve a niente; risorse organizzative senza di che è impossibile gestire sistemi complessi; risorse ambientali e relative alla qualità sociale; e quindi - di conseguenza - beni cosiddetti «relazionali», cioè rapporti sociali e istituzioni capaci di produrre fiducia, cooperazione tra pubblico e privato. Insomma un nuovo ethos civile, essendo questo il solo modo per dare ai «poveri» la possibilità di non essere messi ai margini. Far emergere, in alternativa alla ricetta neo-liberista, l'altra possibilità insita nel post-industriale, e cioè il fatto che una nuova coesione sociale può diventare lo strumento più efficace per competere.
Forse non è una grande scoperta. Ma a me sembra il solo modo per la sinistra di dare un fondamento strategico alla sua iniziativa, intendendo la strategia come la capacità di spostare i rapporti di forza e di intervenire dentro i processi reali, volgendo a proprio vantaggio la dinamica oggettiva dei cambiamenti che si producono. Abbiamo bisogno di una nuova analisi politica per capire se nella realtà effettuale, e non nei nostri desideri, sono aperte delle contraddizioni e delle linee di conflitto sulle quali si possa innestare una grande iniziativa politica. (da l' Unità, 03-07-2007)






 Perchè spesso la
Perchè spesso la  22 parole per un linguaggio nuovo della politica.
Clicca
22 parole per un linguaggio nuovo della politica.
Clicca 








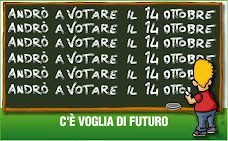


Nessun commento:
Posta un commento