di Pietro Scoppola
Sono grato a Romano Prodi per avermi chiesto di aprire questo seminario. I. Nella sua lettera di invito Prodi indica chiaramente le ragioni che ispirano la proposta di dar vita a un partito democratico: caduti i motivi che in una lunga stagione storica hanno diviso le forze democratiche e riformatrici, occorre, in un sistema bipolare “trasparente e moderno”, dar vita a un soggetto capace di raccogliere la domanda di unità e di cambiamento che sale dal Paese. L’obiettivo è quello di condurre in porto “quel processo politico che dopo anni di sforzi ed esperimenti, ha portato, anche attraverso le primarie del 16 ottobre 2005, alla decisione di proporre la lista unitaria dell’Ulivo alla Camera”. Il cenno alle primarie indica la volontà di una apertura a realtà popolari, ad associazioni e a personalità che hanno lavorato per l’Ulivo e poi per il Partito democratico. Ma è esplicito nella lettera il richiamo ai partiti che hanno dato voce e rappresentanza alle tradizioni riformatrici e sono parte fondamentale e costitutiva della Repubblica e dello Stato democratico. Perciò -dice Prodi- “dobbiamo immaginare un percorso in cui le scelte e le decisioni dei partiti (nei loro organi decisionali fino ai congressi) si incontrino e convergano con una platea di soggetti più ampia e meno o diversamente strutturata”. I partiti sono perciò i principali protagonisti del processo verso il partito democratico che Romano Prodi propone. E’ inevitabile che sia così come era inevitabile -se è consentito un paradossale richiamo storico- che i sovrani assoluti, i detentori del potere, quando erano costretti dagli eventi, concedessero le costituzioni. L’alternativa era solo la rivoluzione i cui esiti, peraltro, come la storia insegna, sono stati sempre ricondotti entro un equilibrio fra vecchi e nuovi poteri. Voglio dire insomma che nella proposta di Prodi non c’è un azzeramento dell’esistente, non c’è e non ci poteva essere uno scioglimento preventivo dei partiti. I partiti sono e rimangono protagonisti della transizione. Ho richiamato questo dato della decisiva rilevanza dei partiti solo perché di qui nascono le difficoltà, le tensioni con cui dobbiamo misurarci. Dice Prodi nella sua lettera: “in tutte le obiezioni che vengono mosse al progetto [....] c’è qualcosa di vero”. Ma noi, prosegue, dobbiamo tener conto di tutti i dubbi e non farci bloccare. Effettivamente le polemiche intorno alla proposta di un partito democratico sono tante e così piene di equivoci da esigere il massimo di chiarezza e onestà intellettuale. Tener conto di quei dubbi significa anzitutto capirne le ragioni. La prima domanda da porsi è quella più radicale: il partito non è ormai una forma vuota ed anzi rifiutata per la partecipazione alla vita politica? Non rischia di servire solo per consentire alle oligarchie di sopravvivere, come è avvenuto in altri campi, in economia, nella finanza, quando attraverso fusioni, incorporazioni, od operazioni straordinarie sul capitale, capi deboli o azionisti di minoranza hanno preteso di conservare il loro potere? Le reazioni di molti all’idea del partito democratico sono il segno di problemi reali, di verità da non nascondere. E allora appena riconosciuto realisticamente il ruolo prevalente e, per restare nel paradosso storico, il carattere octroyé del partito democratico, bisogna porre al giusto livello le condizioni perché l’operazione sia possibile e al tempo stesso credibile ed efficace. La centralità del ruolo dei partiti non poteva non provocare le reazioni identitarie, a sinistra come al centro. A sinistra si teme di perdere un’identità che ha radici profonde nella nostra storia e che ha indubbiamente contribuito a fare del nostro Paese una democrazia veramente popolare, ha sostenuto rivendicazioni fondamentali di libertà e di giustizia. Ma la sinistra, nel partito democratico, può guardare al futuro. I cattolici democratici non possono accettare il pur cortese invito a ritrovarsi in Europa nella casa socialista, come se fossero dei nostalgici o degli sconfitti. Consentitemi un rinvio alla prefazione scritta “a quattro mani” con Beppe Tognon alla seconda edizione dell’ intervista su La Democrazia dei cristiani. Quello che è avvenuto in Francia, con figure di grande prestigio come un Delors, non può avvenire in Italia per tre ragioni che si riassumono in tre parole: per la forza maggiore nel nostro Paese della tradizione politica cattolico democratica, per la debolezza della tradizione socialdemocratica e per il peso dell’eredità comunista nella nostra storia. E quando dico peso, dico importanza, forza di condizionamento della nostra società e della vita politica, in positivo e in negativo. E per un’ulteriore ragione alla quale tutti i democratici dovrebbero essere sensibili: perché spingerebbe irrimediabilmente verso una destra senza storia la Chiesa italiana vanificando lo sforzo di due generazioni di democratici cristiani da De Gasperi a Moro che hanno lavorato con passione, con sofferenza, ma con frutto per tenere la Chiesa agganciata alla democrazia, per l’ “istituzione della democrazia nel mondo cristiano” per dirla con Tocqueville. E’stato più difficile che altrove per la Chiesa italiana adattarsi ad uno schema bipolare: evitiamo di favorire il riflusso verso destra di questa Chiesa. Non è un caso che si sia affidata, di nuovo, a Romano Prodi, la guida del governo non solo per la sua indiscussa competenza, ma anche, io credo, perché nella sua formazione non è certo assente il cattolicesimo democratico. Il problema della collocazione europea, dovrebbe essere semplicemente rinviato a dopo la nascita del partito, quando i suoi aderenti potranno far sentire la loro voce. Non penso che i problemi cosiddetti eticamente sensibili rappresentino un ostacolo insuperabile purché siano assunti come problemi da risolvere e non come pretesto per dividersi e purché si sappia collocarli in una dimensione pienamente consapevole della complessità del rapporto oggi esistente fra la scienza e una tecnologia che ha ambizioni di onnipotenza. Dunque i partiti del centro sinistra facciano i passi possibili sulla via dell’unità: unità di liste, unità di gruppi, momenti assembleari aperti alla partecipazione di non iscritti ai partiti, assemblee costituenti a livello territoriale. Naturalmente l’esito dipenderà dalla regia e c’è da augurarsi che la regia sia illuminata ed aperta a questi sviluppi e perciò sia affidata ad un organismo sufficientemente libero e indipendente dalle logiche di partito. C’è da augurarsi che una costituente del partito democratico, se ad essa si arriverà, sia formata sulla base di una partecipazione larga ed aperta. Una questione pregiudiziale è quella della riforma elettorale. Abbiamo una legge elettorale che esaspera il potere dei gruppi dirigenti dei partiti, che taglia ogni legame fra gli elettori e gli eletti e che è funzionale ad una partitocrazia..... senza veri partiti. Bisogna dirlo chiaramente: senza riforma elettorale il partito democratico non può mettere radici; ma la determinazione dei partiti su questo tema, dopo l’appello di Prodi per una riforma, appare assai incerta. Altro elemento qualificante del nuovo partito dovrebbe essere a mio avviso l’applicazione del famoso artico 49 della Costituzione anche alla vita interna dei partiti. Ai molti che in questi anni hanno con generosità aiutato Prodi e l’Ulivo. alle numerose associazioni che si battono per il nuovo partito, a tutti quanti hanno creduto e sperato nell’Ulivo e ora nel Partito democratico io direi: prendiamo atto dei passi oggi possibili, ma teniamo viva una idea, una speranza più impegnativa e giochiamola non contro il processo ma oltre, oltre questo processo oggi possibile, quando scelte più impegnative saranno necessarie. Teniamo viva l’idea di un vero partito nuovo. II. Ma quale partito nuovo? Quale è il suo retroterra sociale e culturale? A quali riserve si può attingere? Come fare per metterle in circolo? Storicamente i partiti nascono per rappresentare interessi e valori emergenti che non hanno spazio nella realtà sociale e politica e vogliono conquistarlo: così il partito liberale, così il partito socialista, così il partito popolare e poi i comunisti, la Democrazia cristiana, e più tardi gli ambientalisti, i verdi. Cosa di nuovo dovrebbe rappresentare il partito democratico, a quali interessi, a quali valori, a quali domande dovrebbe rispondere? Certo c’è un problema di difesa, di conservazione, con i necessari aggiornamenti, delle conquiste del periodo precedente alle quali hanno contribuito in forme diverse socialisti e cattolici: intendo la difesa del Welfare dalla sfida della globalizzazione. Ma questa è una funzione di sostanziale, legittima conservazione delle conquiste conseguite, una funzione che da sola non può innervare culturalmente un partito nuovo. Dobbiamo chiederci quali sono le domande inevase che giustificano la nascita di un partito nuovo: sono le domande, i problemi che il secolo scorso ha lasciati irrisolti, legati tutti a un intreccio di beni e interessi materiali e immateriali. Dobbiamo scavare nella eredità del vecchio secolo per guardare al futuro. Provo a indicare alcuni di questi nodi. Non posso fare a meno di riprendere alcune idee già enunciate a Chianciano nel convegno dei Popolari il 27 scorso. Il secolo scorso è stato dominato dalla domanda assillante su come rispondere alla sfida di una modernità che metteva in crisi tutte le vecchie identità tradizionali. Gran parte del ‘900 è stato attraversato dalla nostalgia per la “coesione sociale”, una nostalgia che ha condizionato le diverse ideologie. I totalitarismi di destra hanno tentato di rispondere a loro modo, rifiutando la pluralità, la complessità, attraverso la sacralizzazione della nazione, dello stato, della razza. Anche il comunismo si è posto lo stesso problema; la sua risposta è stata abissalmente diversa nella prospettiva del futuro da costruire -un futuro di libertà e di uguaglianza – ma è stata tuttavia travolta, dagli strumenti di governo e di repressione adottati. Questo scarto totale fra obiettivi ideali e realizzazione storica ha messo radicalmente in crisi tutta l’ideologia ispiratrice del comunismo. In definitiva la democrazia ha vinto: in Italia un ruolo importante per la sua vittoria lo hanno certamente avuto la tradizione liberal democratica e liberal socialista; i cattolici democratici, e i comunisti italiani, con la loro diversità, pur sulla base di un aspro conflitto hanno saputo dare alla democrazia un vasto consenso di popolo. Ma la domanda da cui quei movimenti totalitari erano nati–quella esigenza di coesione sociale e in definitiva di nuova identità collettiva- non è stata compiutamente accolta: le identità cui la democrazia ha dato luogo, sulla scia del modello americano, sono risultate legate prevalentemente alle dinamiche della produzione e dei consumi. In Italia la rinascita democratica è stata segnata per giunta dalla fragilità di una comune identità democratica in favore di identità di partito. In fondo, si potrebbe dire che anche la contestazione del ’68 – pur nell’enorme differenza di strumenti e di esiti - è stata animata, in forme contraddittorie e talvolta impazzite, da quel problema di identità. Si pensi ad alcuni temi del movimento: l’infelicità prodotta dall’individualismo, il rifiuto del materialismo, il desiderio di ritrovare un contatto con la natura, l’angoscia per l’isolamento, per l’alienazione prodotta da una società sempre più anonima. Ma anche per il ’68 come per i totalitarismi “tutto era politica”; la politica invadeva la vita quotidiana. Proprio i movimenti di contestazione degli anni ’60 e ’70, e più di recente il movimento cosiddetto “no-global”, hanno mostrato che se la democrazia è riuscita ad integrare le masse popolari nello Stato, se ha prodotto maggiore benessere, se ha distribuito in modo più equo la ricchezza, non ha risposto fino in fondo alle domande, alle paure provocate dalla «modernità». La politica non ha dato e non poteva dare queste risposte. Quando la politica manifesta il suo limite, essa viene travolta da spinte opposte e distruttive: da risposte antidemocratiche o da risposte antipolitiche, che diventano a loro volta antidemocratiche. Risposte antidemocratiche, come nel caso dei movimenti rivoluzionari o dei fondamentalismi di oggi. Risposte antipolitiche, come abbiamo potuto vedere proprio nel nostro paese, anche se i segnali in questa direzione si moltiplicano in altre aree geografiche. Ma le posizioni antipolitiche, che teorizzano un mondo privo di conflitti (e dunque privo di politica), si trovano di fronte all’insanabile contraddizione rappresentata dal fatto che si appellano alla politica – come con la famosa «discesa in campo» del 1994 – per produrre la fine della politica stessa. Si promette cioè di giungere a una situazione in cui una buona amministrazione sostituirà una volta per tutte la politica, ma nello stesso tempo si produce un’estremizzazione dello scontro frontale, la demonizzazione dell’avversario, l’esasperazione dei toni per chiamare alla mobilitazione contro i nemici della libertà individuale. In altre parole, ci si propone di cancellare la dimensione politica con l’uso estremo delle armi fornite dalla politica stessa. III. Il tema della identità si salda con quella che definirei la questione democratica. In sostanza il secolo XX ha segnato il fallimento delle ideologie di liberazione dell’uomo legate al mito dell’uomo nuovo costruito dal potere politico o dalla Stato. Ma ha segnato anche il fallimento del mito di una democrazia spontaneamente capace di assicurare le risposte giuste alle sfide della modernità, di diffondersi, di conquistare terre e popoli nuovi e di autoriprodursi. Già nel suo libro del 1984 Il futuro della democrazia Bobbio osservava che una delle promesse della democrazia era quella di alimentare autonomamente e spontaneamente lo spirito democratico, ma che questa promessa non era stata mantenuta: insomma la democrazia spontaneamente non si alimenta; la democrazia non è autosufficiente. Quella intuizione di Bobbio è stata ripresa e approfondita in una ampia letteratura che è impossibile qui richiamare. La democrazia è in crisi sotto l’effetto della società dei due terzi; è spesso schiava degli interessi costituti, degli interessi forti, più che interprete delle speranze dei deboli. E’ in crisi la democrazia americana: si riprenderà perché ha radici profonde, ma il suo disagio è evidente e sintomatico. La democrazia stenta a rappresentare e a fare sintesi di fronte ad una realtà sempre più complessa e contraddittoria; nel suo recentissimo libro Forme di Stato e forme di governo Giuliano Amato stabilisce un parallelo fra la sfida alla democrazia rappresentata all’inizio del secolo dai totalitarismi e le nuove sfide del nostro tempo che nascono da una esasperata complessità sociale. La crisi della democrazia è anche problema di classi dirigenti. Il passaggio di secolo ha reso visibile la mancanza di grandi figure politiche. La figura di Papa Wojtyla è stata di gran lunga quella dominante. Nessun politico nel mondo ha dominato la scena del passaggio di millennio. Il vecchio secolo ci ha consegnato dunque un problema irrisolto di selezione delle classi dirigenti e di leadership. Ci sono ottimi professionisti sulla scena, ci sono ancora politici che credono in quello che fanno, ma non possiamo negare che nel momento in cui la complessità dei problemi richiederebbe il massimo di apertura a nuove competenze e a nuove generazioni, abbiamo, almeno in Italia, il massimo di autoreferenzialità del sistema politico. La forma partito che abbiamo ereditato dal secolo scorso non è più idonea a selezionare una classe politica all’altezza delle nuove sfide ed è per questo che dobbiamo tenere ben presente la domanda di partenza: quale è il retroterra sociale e culturale del partito democratico? A quali riserve si può attingere? come fare per metterle in circolo? La questione democratica comprende per noi italiani quella della riforma costituzionale. La nostra Costituzione “contesa” alla fine del secolo scorso è stata poi “aggredita”, per riprendere un titolo di Leopoldo Elia, dalla riforma imposta dalla destra nella passata legislatura, ma ha ritrovato il suo radicamento nel recente referendum popolare: il referendum ha confermato e rafforzato quello che in altra sede mi è sembrato di poter definire il triplice radicamento della Costituzione: nella storia d’Italia e in una Resistenza intesa sempre più come vicenda di popolo e non come una guerra civile di minoranze; un radicamento nella grande tradizione del costituzionalismo europeo; un radicamento nella coscienza religiosa del Paese per avere, nel primo comma dell’articolo 7, dato una definitiva risposta alla questione storica della presenza del Papato in Italia. Il rinnovato radicamento non esclude anzi esige una riforma, sulla quale giustamente il Presidente Napolitano ha richiamato ripetutamente l’attenzione, una riforma calibrata sulle nuove esigenze, ma fedele alla tradizione parlamentare e quindi non plebiscitaria, non presidenzialista, non tale da tradurre la spinta alle autonomie in un rischio per la unità nazionale. La giusta esigenza di cercare un ampio consenso intorno alla riforma non può tradursi in cedimento di fronte a principi e valori che il voto popolare del giugno 2006 ha solennemente consacrato. Connessa al tema della riforma è la questione della identità e della unità nazionale che esige un ripensamento della idea di cittadinanza. Oggi non c’è un soggetto sociale, classi o ceti ben determinati da integrare: la realtà è frammentata. Da una parte, è necessario evitare che i soggetti deboli (le nuove povertà) siano espulsi o messi ai margini del sistema; dall’altra, è necessario produrre una nuova integrazione per gli immigrati, che non hanno accesso al benessere prodotto dal nostro modello di sviluppo; infine bisogna ricreare le condizioni per una corretta mobilità sociale fondata sull’impegno e sul merito. È necessario produrre un’integrazione che dia senso dell’appartenenza comune, senso dei diritti e dei doveri, delle regole, della partecipazione attiva e del confronto, che sono tra le eredità più positive lasciateci dal mondo cattolico e dal movimento dei lavoratori. Centrale è dunque la questione della cittadinanza, cioè della piena appartenenza alla comunità politica, che è anche una comunità di culture plurali che si riconoscono reciprocamente, di storie plurali ognuna delle quali trova un posto e un ruolo rispetto alle altre, in cui non ci sono ghetti o isole di esclusione o di autoesclusione. IV. Ma la questione democratica con le sue varie implicazioni è solo un aspetto della eredità del XX secolo. Quella crisi di identità prodotta dalla modernità che ha dominato il secolo scorso assume oggi forme ancor più incisive e allarmanti. Il secolo XX ci ha consegnato un modello di società, un modello di sviluppo (mi riferisco al modello nostro occidentale) in cui il futuro è rigidamente preordinato, in cui non c’è futuro libero. Sappiamo con certezza scientifica che il nostro modello di sviluppo se non subirà modifiche radicali, renderà in un tempo che con qualche approssimazione è stato già calcolato, il pianeta invivibile. Il problema enorme, che tuttavia un partito che guardi al futuro non può non aver presente come orizzonte culturale, è quello della libertà delle future generazioni oggi chiuse, e per questo senza speranza e fiducia nel futuro, in un ferreo determinismo. Il secolo scorso che si aprì nel clima ingenuo di una sconfinata fiducia nella possibilità della scienza di operare per la liberazione dell’uomo, ci consegna in eredità la drammatica coscienza di un progresso tecnologico che sfugge alla possibilità di ogni controllo. Abbiamo bisogno di cercare e inventare nuovi modelli di sviluppo: gioverebbe forse a questo fine prestare attenzione alle voci che ci vengono da lontane civiltà asiatiche che propongono di sostituire al prodotto interno lordo, come indice di progresso, l’indice della complessiva felicità nazionale. E’ cresciuta la dimensione reale e la coscienza dell’ insostenibile rapporto fra il Nord e il Sud del pianeta, un rapporto che, così come sta oggi, non può durare. Il rapporto attuale fra popolazione e risorse nelle diverse aree del pianeta non è sostenibile: il fenomeno delle immigrazioni sarà sempre più massiccio senza interventi che vadano alle radici del problema. Su questi temi pesa l’eredità di una lunga storia dei processi di colonizzazione e decolonizzazione che chiamano direttamente in causa l’Europa. Il fattore religioso è riemerso sulla scena mondiale in primo piano, ma ha assunto anche, specie nell’Islam, forme fondamentaliste che rappresentano una sfida imprevedibile e inquietante alla democrazia e ai valori liberali: proprio a questi valori il fondamentalismo islamico attribuisce la responsabilità della crisi del tessuto etico religioso della società occidentale verso la quale concentra perciò la sua polemica e il suo attacco. Guai ai corti circuiti e alle semplificazioni culturali, ma il fatto che il secolo si sia aperto con la tragedia dell’11 settembre non è certo casuale. La risposta non può essere la rinuncia alla libertà religiosa e alla laicità dello Stato ma dobbiamo forse ripensare la laicità in termini che non escludano anzi valorizzino l’apporto delle esperienze religiose alla formazione del tessuto etico della società. Se non vogliamo che del fattore religioso, del cristianesimo, si impadroniscano i teocon, con l’effetto di favorire uno scontro di civiltà in cui di fatto i valori di libertà cui essi si appellano, quando parlano di Occidente, sarebbero radicalmente compromessi. Il terrorismo ha avuto una sua prima vittoria nel porre in crisi, con il Patriot Act i principi stessi dell’habeas corpus, fondamento del liberalismo. Dahrendorf segnalava pochi giorni fa come uno scandalo la “nuova teoria” enunciata dal primo ministro inglese Blair, secondo cui la sicurezza sarebbe la prima delle libertà, una sicurezza della quale lo Stato definisce le condizioni anche limitando la libertà dei cittadini. Così al senso di dipendenza e di frustrazione prodotto da un determinismo frutto del sistema economico e dalla rincorsa tecnologica si aggiunge un secondo motivo di insicurezza tutto interno alle responsabilità politiche e religiose: la crisi nel rapporto tra i popoli e le religioni. La libertà dal determinismo, la liberazione dalla paura e la riscoperta della speranza come spazio vitale necessario alle nuove generazioni non sono certo obiettivi facili, alla portata soltanto di un partito politico, sono tuttavia elemento essenziale di una cultura che un partito democratico deve coltivare. Tutto si inquadra in una visione europeistica e internazionalistica che non deve essere un punto del programma del nuovo partito ma una sua connotazione essenziale. Ma l’incertezza che assilla le nuove generazioni ha altri aspetti che sono parte essenziale di una nuova domanda di politica. Si pensi alla possibilità e alla stabilità del lavoro, alle garanzie per la vecchiaia e per la malattia, insomma a quello che il welfare aveva conquistato e la globalizzazione ha messo in discussione. Qui il rischio è quello di una difesa quantitativa che si risolva in un progressivo arretramento senza un salto di qualità. Quello che l’individuo della società preindustriale trovava nella grande famiglia patriarcale di un tempo e che l’individuo isolato e la famiglia nucleare della società industriale ha cercato e trovato, almeno in parte, nello Stato sociale, deve essere ricuperato sul terreno di un tessuto sociale nuovo che alla solitudine dell’uomo moderno risponda con un tessuto libero di amicizie. L’amicizia contro la solitudine, l’amicizia come l’etimologia suggerisce che nasce dall’amore e non l’amicizia politica anticamera di corruzione. La riforma del Welfare in altre parole non è questione di quantità o di tagli, ma di riconversione qualitativa nel senso di un coinvolgimento di tutto il tessuto sociale su valori di convivenza. solidarietà, amicizia appunto. Non si tratta solo di vecchiaia o di malattia: si tratta anche di socializzazione di giovani e giovanissimi. Si pensi ai bambini e ai ragazzi la cui socializzazione è affidata oggi alla vita di banda nelle strade, a rumorose sale da gioco, alla pratica non dello sport ma del fanatismo sportivo, alla televisione. Perché non pensare ad una funzione più ampia della scuola e ad una valorizzazione, con opportuni incentivi, di tutte le iniziative esistenti nel quadro di una applicazione larga, non gelosa, del principio di sussidiarietà. Ecco: crisi di identità e questione democratica, determinismo e libertà, paura e speranza di futuro, solitudine e amicizia, sono queste alcune delle dicotomie sulle quali un partito nuovo dovrebbe costruire la sua identità e il suo progetto. I miei sono solo esempi: il discorso avrebbe bisogno di ben altri sviluppi e ben altre competenze. Ma questi accenni sono sufficienti per comprendere che un partito che si muova in un simile orizzonte culturale esige una struttura del tutto nuova, tutta da inventare, una nuova forma partito. Non si tratta di mettere insieme pezzi di classi dirigente portatori di tradizioni culturali di partito, spesso ossificate, ma pezzi di popolo, milioni di cittadini personalmente coinvolti ciascuno con la sua storia, la sua cultura, la sua sensibilità. L’apporto delle diverse culture e tradizioni democratiche è essenziale purché non si scambi questa feconda integrazione solo con un incontro e una intesa dei gruppi dirigenti dei partiti. Le sfide per la democrazia oggi riguardano la possibilità di restituire fiducia nella capacità costruttiva della politica, nell’utopia democratica, di restituire a quest’ultima nuovo vigore. V. Ripeto: i gruppi dirigenti dei partiti e i partiti si incontrino e diano vita per quanto possibile a un nuovo soggetto unitario ma avvertano il rischio e la tremenda responsabilità delle parole: il rischio che le speranze cresciute in questi anni, che negli ultimi mesi i partiti stessi hanno acceso e diffuso e che hanno dato vita ad un significativo protagonismo femminile, ad una mobilitazione di popolo che ha coinvolto milioni di donne, di uomini e di giovani diventino nuove delusioni. Non si può ripetere all’infinito che il paese è maturo per un partito democratico, che c’è una diffusa domanda di base, senza compiere poi atti conseguenti, seri ed efficaci. I partiti facciano i passi oggi possibili, ma lascino aperta una grande finestra verso il futuro. E teniamo noi tutti, cittadini della Repubblica. viva dentro e fuori i partiti una prospettiva più ampia, un disegno più ambizioso, una tensione ideale che superi le singole appartenenze, che non guardi più alle componenti come realtà separate e non comunicanti, ma piuttosto esalti i valori comuni. alori comuni da cercare proprio nella nostra Costituzione. Si discusse alla Costituente se la nuova Costituzione dovesse avere un presupposto ideologico e un punto di incontro fu trovato nell’idea della dignità della persona umana. Era una idea di matrice cristiana che laicamente declinata ispirò largamente il testo costituzionale. Mi chiedo se quella intuizione che ha fondato non solo tutte le tradizionali libertà ma il principio di uguaglianza e il rifiuto della guerra non possa diventare principio animatore della vita associata, non possa ispirare una laicità e una libertà di coscienza e di religione che non neghino, anzi valorizzano, l’apporto delle esperienze religiose alla vita sociale, non possa animare non solo le iniziative statali di welfare, ma uno spirito di solidarietà (di amicizia) in tutto il tessuto sociale, non possa sollecitare la ricerca di nuovi modelli di sviluppo. Il partito democratico può trovare in questo patrimonio di valori la sua stella polare.
Orvieto, 6 ottobre 2006
Sono grato a Romano Prodi per avermi chiesto di aprire questo seminario. I. Nella sua lettera di invito Prodi indica chiaramente le ragioni che ispirano la proposta di dar vita a un partito democratico: caduti i motivi che in una lunga stagione storica hanno diviso le forze democratiche e riformatrici, occorre, in un sistema bipolare “trasparente e moderno”, dar vita a un soggetto capace di raccogliere la domanda di unità e di cambiamento che sale dal Paese. L’obiettivo è quello di condurre in porto “quel processo politico che dopo anni di sforzi ed esperimenti, ha portato, anche attraverso le primarie del 16 ottobre 2005, alla decisione di proporre la lista unitaria dell’Ulivo alla Camera”. Il cenno alle primarie indica la volontà di una apertura a realtà popolari, ad associazioni e a personalità che hanno lavorato per l’Ulivo e poi per il Partito democratico. Ma è esplicito nella lettera il richiamo ai partiti che hanno dato voce e rappresentanza alle tradizioni riformatrici e sono parte fondamentale e costitutiva della Repubblica e dello Stato democratico. Perciò -dice Prodi- “dobbiamo immaginare un percorso in cui le scelte e le decisioni dei partiti (nei loro organi decisionali fino ai congressi) si incontrino e convergano con una platea di soggetti più ampia e meno o diversamente strutturata”. I partiti sono perciò i principali protagonisti del processo verso il partito democratico che Romano Prodi propone. E’ inevitabile che sia così come era inevitabile -se è consentito un paradossale richiamo storico- che i sovrani assoluti, i detentori del potere, quando erano costretti dagli eventi, concedessero le costituzioni. L’alternativa era solo la rivoluzione i cui esiti, peraltro, come la storia insegna, sono stati sempre ricondotti entro un equilibrio fra vecchi e nuovi poteri. Voglio dire insomma che nella proposta di Prodi non c’è un azzeramento dell’esistente, non c’è e non ci poteva essere uno scioglimento preventivo dei partiti. I partiti sono e rimangono protagonisti della transizione. Ho richiamato questo dato della decisiva rilevanza dei partiti solo perché di qui nascono le difficoltà, le tensioni con cui dobbiamo misurarci. Dice Prodi nella sua lettera: “in tutte le obiezioni che vengono mosse al progetto [....] c’è qualcosa di vero”. Ma noi, prosegue, dobbiamo tener conto di tutti i dubbi e non farci bloccare. Effettivamente le polemiche intorno alla proposta di un partito democratico sono tante e così piene di equivoci da esigere il massimo di chiarezza e onestà intellettuale. Tener conto di quei dubbi significa anzitutto capirne le ragioni. La prima domanda da porsi è quella più radicale: il partito non è ormai una forma vuota ed anzi rifiutata per la partecipazione alla vita politica? Non rischia di servire solo per consentire alle oligarchie di sopravvivere, come è avvenuto in altri campi, in economia, nella finanza, quando attraverso fusioni, incorporazioni, od operazioni straordinarie sul capitale, capi deboli o azionisti di minoranza hanno preteso di conservare il loro potere? Le reazioni di molti all’idea del partito democratico sono il segno di problemi reali, di verità da non nascondere. E allora appena riconosciuto realisticamente il ruolo prevalente e, per restare nel paradosso storico, il carattere octroyé del partito democratico, bisogna porre al giusto livello le condizioni perché l’operazione sia possibile e al tempo stesso credibile ed efficace. La centralità del ruolo dei partiti non poteva non provocare le reazioni identitarie, a sinistra come al centro. A sinistra si teme di perdere un’identità che ha radici profonde nella nostra storia e che ha indubbiamente contribuito a fare del nostro Paese una democrazia veramente popolare, ha sostenuto rivendicazioni fondamentali di libertà e di giustizia. Ma la sinistra, nel partito democratico, può guardare al futuro. I cattolici democratici non possono accettare il pur cortese invito a ritrovarsi in Europa nella casa socialista, come se fossero dei nostalgici o degli sconfitti. Consentitemi un rinvio alla prefazione scritta “a quattro mani” con Beppe Tognon alla seconda edizione dell’ intervista su La Democrazia dei cristiani. Quello che è avvenuto in Francia, con figure di grande prestigio come un Delors, non può avvenire in Italia per tre ragioni che si riassumono in tre parole: per la forza maggiore nel nostro Paese della tradizione politica cattolico democratica, per la debolezza della tradizione socialdemocratica e per il peso dell’eredità comunista nella nostra storia. E quando dico peso, dico importanza, forza di condizionamento della nostra società e della vita politica, in positivo e in negativo. E per un’ulteriore ragione alla quale tutti i democratici dovrebbero essere sensibili: perché spingerebbe irrimediabilmente verso una destra senza storia la Chiesa italiana vanificando lo sforzo di due generazioni di democratici cristiani da De Gasperi a Moro che hanno lavorato con passione, con sofferenza, ma con frutto per tenere la Chiesa agganciata alla democrazia, per l’ “istituzione della democrazia nel mondo cristiano” per dirla con Tocqueville. E’stato più difficile che altrove per la Chiesa italiana adattarsi ad uno schema bipolare: evitiamo di favorire il riflusso verso destra di questa Chiesa. Non è un caso che si sia affidata, di nuovo, a Romano Prodi, la guida del governo non solo per la sua indiscussa competenza, ma anche, io credo, perché nella sua formazione non è certo assente il cattolicesimo democratico. Il problema della collocazione europea, dovrebbe essere semplicemente rinviato a dopo la nascita del partito, quando i suoi aderenti potranno far sentire la loro voce. Non penso che i problemi cosiddetti eticamente sensibili rappresentino un ostacolo insuperabile purché siano assunti come problemi da risolvere e non come pretesto per dividersi e purché si sappia collocarli in una dimensione pienamente consapevole della complessità del rapporto oggi esistente fra la scienza e una tecnologia che ha ambizioni di onnipotenza. Dunque i partiti del centro sinistra facciano i passi possibili sulla via dell’unità: unità di liste, unità di gruppi, momenti assembleari aperti alla partecipazione di non iscritti ai partiti, assemblee costituenti a livello territoriale. Naturalmente l’esito dipenderà dalla regia e c’è da augurarsi che la regia sia illuminata ed aperta a questi sviluppi e perciò sia affidata ad un organismo sufficientemente libero e indipendente dalle logiche di partito. C’è da augurarsi che una costituente del partito democratico, se ad essa si arriverà, sia formata sulla base di una partecipazione larga ed aperta. Una questione pregiudiziale è quella della riforma elettorale. Abbiamo una legge elettorale che esaspera il potere dei gruppi dirigenti dei partiti, che taglia ogni legame fra gli elettori e gli eletti e che è funzionale ad una partitocrazia..... senza veri partiti. Bisogna dirlo chiaramente: senza riforma elettorale il partito democratico non può mettere radici; ma la determinazione dei partiti su questo tema, dopo l’appello di Prodi per una riforma, appare assai incerta. Altro elemento qualificante del nuovo partito dovrebbe essere a mio avviso l’applicazione del famoso artico 49 della Costituzione anche alla vita interna dei partiti. Ai molti che in questi anni hanno con generosità aiutato Prodi e l’Ulivo. alle numerose associazioni che si battono per il nuovo partito, a tutti quanti hanno creduto e sperato nell’Ulivo e ora nel Partito democratico io direi: prendiamo atto dei passi oggi possibili, ma teniamo viva una idea, una speranza più impegnativa e giochiamola non contro il processo ma oltre, oltre questo processo oggi possibile, quando scelte più impegnative saranno necessarie. Teniamo viva l’idea di un vero partito nuovo. II. Ma quale partito nuovo? Quale è il suo retroterra sociale e culturale? A quali riserve si può attingere? Come fare per metterle in circolo? Storicamente i partiti nascono per rappresentare interessi e valori emergenti che non hanno spazio nella realtà sociale e politica e vogliono conquistarlo: così il partito liberale, così il partito socialista, così il partito popolare e poi i comunisti, la Democrazia cristiana, e più tardi gli ambientalisti, i verdi. Cosa di nuovo dovrebbe rappresentare il partito democratico, a quali interessi, a quali valori, a quali domande dovrebbe rispondere? Certo c’è un problema di difesa, di conservazione, con i necessari aggiornamenti, delle conquiste del periodo precedente alle quali hanno contribuito in forme diverse socialisti e cattolici: intendo la difesa del Welfare dalla sfida della globalizzazione. Ma questa è una funzione di sostanziale, legittima conservazione delle conquiste conseguite, una funzione che da sola non può innervare culturalmente un partito nuovo. Dobbiamo chiederci quali sono le domande inevase che giustificano la nascita di un partito nuovo: sono le domande, i problemi che il secolo scorso ha lasciati irrisolti, legati tutti a un intreccio di beni e interessi materiali e immateriali. Dobbiamo scavare nella eredità del vecchio secolo per guardare al futuro. Provo a indicare alcuni di questi nodi. Non posso fare a meno di riprendere alcune idee già enunciate a Chianciano nel convegno dei Popolari il 27 scorso. Il secolo scorso è stato dominato dalla domanda assillante su come rispondere alla sfida di una modernità che metteva in crisi tutte le vecchie identità tradizionali. Gran parte del ‘900 è stato attraversato dalla nostalgia per la “coesione sociale”, una nostalgia che ha condizionato le diverse ideologie. I totalitarismi di destra hanno tentato di rispondere a loro modo, rifiutando la pluralità, la complessità, attraverso la sacralizzazione della nazione, dello stato, della razza. Anche il comunismo si è posto lo stesso problema; la sua risposta è stata abissalmente diversa nella prospettiva del futuro da costruire -un futuro di libertà e di uguaglianza – ma è stata tuttavia travolta, dagli strumenti di governo e di repressione adottati. Questo scarto totale fra obiettivi ideali e realizzazione storica ha messo radicalmente in crisi tutta l’ideologia ispiratrice del comunismo. In definitiva la democrazia ha vinto: in Italia un ruolo importante per la sua vittoria lo hanno certamente avuto la tradizione liberal democratica e liberal socialista; i cattolici democratici, e i comunisti italiani, con la loro diversità, pur sulla base di un aspro conflitto hanno saputo dare alla democrazia un vasto consenso di popolo. Ma la domanda da cui quei movimenti totalitari erano nati–quella esigenza di coesione sociale e in definitiva di nuova identità collettiva- non è stata compiutamente accolta: le identità cui la democrazia ha dato luogo, sulla scia del modello americano, sono risultate legate prevalentemente alle dinamiche della produzione e dei consumi. In Italia la rinascita democratica è stata segnata per giunta dalla fragilità di una comune identità democratica in favore di identità di partito. In fondo, si potrebbe dire che anche la contestazione del ’68 – pur nell’enorme differenza di strumenti e di esiti - è stata animata, in forme contraddittorie e talvolta impazzite, da quel problema di identità. Si pensi ad alcuni temi del movimento: l’infelicità prodotta dall’individualismo, il rifiuto del materialismo, il desiderio di ritrovare un contatto con la natura, l’angoscia per l’isolamento, per l’alienazione prodotta da una società sempre più anonima. Ma anche per il ’68 come per i totalitarismi “tutto era politica”; la politica invadeva la vita quotidiana. Proprio i movimenti di contestazione degli anni ’60 e ’70, e più di recente il movimento cosiddetto “no-global”, hanno mostrato che se la democrazia è riuscita ad integrare le masse popolari nello Stato, se ha prodotto maggiore benessere, se ha distribuito in modo più equo la ricchezza, non ha risposto fino in fondo alle domande, alle paure provocate dalla «modernità». La politica non ha dato e non poteva dare queste risposte. Quando la politica manifesta il suo limite, essa viene travolta da spinte opposte e distruttive: da risposte antidemocratiche o da risposte antipolitiche, che diventano a loro volta antidemocratiche. Risposte antidemocratiche, come nel caso dei movimenti rivoluzionari o dei fondamentalismi di oggi. Risposte antipolitiche, come abbiamo potuto vedere proprio nel nostro paese, anche se i segnali in questa direzione si moltiplicano in altre aree geografiche. Ma le posizioni antipolitiche, che teorizzano un mondo privo di conflitti (e dunque privo di politica), si trovano di fronte all’insanabile contraddizione rappresentata dal fatto che si appellano alla politica – come con la famosa «discesa in campo» del 1994 – per produrre la fine della politica stessa. Si promette cioè di giungere a una situazione in cui una buona amministrazione sostituirà una volta per tutte la politica, ma nello stesso tempo si produce un’estremizzazione dello scontro frontale, la demonizzazione dell’avversario, l’esasperazione dei toni per chiamare alla mobilitazione contro i nemici della libertà individuale. In altre parole, ci si propone di cancellare la dimensione politica con l’uso estremo delle armi fornite dalla politica stessa. III. Il tema della identità si salda con quella che definirei la questione democratica. In sostanza il secolo XX ha segnato il fallimento delle ideologie di liberazione dell’uomo legate al mito dell’uomo nuovo costruito dal potere politico o dalla Stato. Ma ha segnato anche il fallimento del mito di una democrazia spontaneamente capace di assicurare le risposte giuste alle sfide della modernità, di diffondersi, di conquistare terre e popoli nuovi e di autoriprodursi. Già nel suo libro del 1984 Il futuro della democrazia Bobbio osservava che una delle promesse della democrazia era quella di alimentare autonomamente e spontaneamente lo spirito democratico, ma che questa promessa non era stata mantenuta: insomma la democrazia spontaneamente non si alimenta; la democrazia non è autosufficiente. Quella intuizione di Bobbio è stata ripresa e approfondita in una ampia letteratura che è impossibile qui richiamare. La democrazia è in crisi sotto l’effetto della società dei due terzi; è spesso schiava degli interessi costituti, degli interessi forti, più che interprete delle speranze dei deboli. E’ in crisi la democrazia americana: si riprenderà perché ha radici profonde, ma il suo disagio è evidente e sintomatico. La democrazia stenta a rappresentare e a fare sintesi di fronte ad una realtà sempre più complessa e contraddittoria; nel suo recentissimo libro Forme di Stato e forme di governo Giuliano Amato stabilisce un parallelo fra la sfida alla democrazia rappresentata all’inizio del secolo dai totalitarismi e le nuove sfide del nostro tempo che nascono da una esasperata complessità sociale. La crisi della democrazia è anche problema di classi dirigenti. Il passaggio di secolo ha reso visibile la mancanza di grandi figure politiche. La figura di Papa Wojtyla è stata di gran lunga quella dominante. Nessun politico nel mondo ha dominato la scena del passaggio di millennio. Il vecchio secolo ci ha consegnato dunque un problema irrisolto di selezione delle classi dirigenti e di leadership. Ci sono ottimi professionisti sulla scena, ci sono ancora politici che credono in quello che fanno, ma non possiamo negare che nel momento in cui la complessità dei problemi richiederebbe il massimo di apertura a nuove competenze e a nuove generazioni, abbiamo, almeno in Italia, il massimo di autoreferenzialità del sistema politico. La forma partito che abbiamo ereditato dal secolo scorso non è più idonea a selezionare una classe politica all’altezza delle nuove sfide ed è per questo che dobbiamo tenere ben presente la domanda di partenza: quale è il retroterra sociale e culturale del partito democratico? A quali riserve si può attingere? come fare per metterle in circolo? La questione democratica comprende per noi italiani quella della riforma costituzionale. La nostra Costituzione “contesa” alla fine del secolo scorso è stata poi “aggredita”, per riprendere un titolo di Leopoldo Elia, dalla riforma imposta dalla destra nella passata legislatura, ma ha ritrovato il suo radicamento nel recente referendum popolare: il referendum ha confermato e rafforzato quello che in altra sede mi è sembrato di poter definire il triplice radicamento della Costituzione: nella storia d’Italia e in una Resistenza intesa sempre più come vicenda di popolo e non come una guerra civile di minoranze; un radicamento nella grande tradizione del costituzionalismo europeo; un radicamento nella coscienza religiosa del Paese per avere, nel primo comma dell’articolo 7, dato una definitiva risposta alla questione storica della presenza del Papato in Italia. Il rinnovato radicamento non esclude anzi esige una riforma, sulla quale giustamente il Presidente Napolitano ha richiamato ripetutamente l’attenzione, una riforma calibrata sulle nuove esigenze, ma fedele alla tradizione parlamentare e quindi non plebiscitaria, non presidenzialista, non tale da tradurre la spinta alle autonomie in un rischio per la unità nazionale. La giusta esigenza di cercare un ampio consenso intorno alla riforma non può tradursi in cedimento di fronte a principi e valori che il voto popolare del giugno 2006 ha solennemente consacrato. Connessa al tema della riforma è la questione della identità e della unità nazionale che esige un ripensamento della idea di cittadinanza. Oggi non c’è un soggetto sociale, classi o ceti ben determinati da integrare: la realtà è frammentata. Da una parte, è necessario evitare che i soggetti deboli (le nuove povertà) siano espulsi o messi ai margini del sistema; dall’altra, è necessario produrre una nuova integrazione per gli immigrati, che non hanno accesso al benessere prodotto dal nostro modello di sviluppo; infine bisogna ricreare le condizioni per una corretta mobilità sociale fondata sull’impegno e sul merito. È necessario produrre un’integrazione che dia senso dell’appartenenza comune, senso dei diritti e dei doveri, delle regole, della partecipazione attiva e del confronto, che sono tra le eredità più positive lasciateci dal mondo cattolico e dal movimento dei lavoratori. Centrale è dunque la questione della cittadinanza, cioè della piena appartenenza alla comunità politica, che è anche una comunità di culture plurali che si riconoscono reciprocamente, di storie plurali ognuna delle quali trova un posto e un ruolo rispetto alle altre, in cui non ci sono ghetti o isole di esclusione o di autoesclusione. IV. Ma la questione democratica con le sue varie implicazioni è solo un aspetto della eredità del XX secolo. Quella crisi di identità prodotta dalla modernità che ha dominato il secolo scorso assume oggi forme ancor più incisive e allarmanti. Il secolo XX ci ha consegnato un modello di società, un modello di sviluppo (mi riferisco al modello nostro occidentale) in cui il futuro è rigidamente preordinato, in cui non c’è futuro libero. Sappiamo con certezza scientifica che il nostro modello di sviluppo se non subirà modifiche radicali, renderà in un tempo che con qualche approssimazione è stato già calcolato, il pianeta invivibile. Il problema enorme, che tuttavia un partito che guardi al futuro non può non aver presente come orizzonte culturale, è quello della libertà delle future generazioni oggi chiuse, e per questo senza speranza e fiducia nel futuro, in un ferreo determinismo. Il secolo scorso che si aprì nel clima ingenuo di una sconfinata fiducia nella possibilità della scienza di operare per la liberazione dell’uomo, ci consegna in eredità la drammatica coscienza di un progresso tecnologico che sfugge alla possibilità di ogni controllo. Abbiamo bisogno di cercare e inventare nuovi modelli di sviluppo: gioverebbe forse a questo fine prestare attenzione alle voci che ci vengono da lontane civiltà asiatiche che propongono di sostituire al prodotto interno lordo, come indice di progresso, l’indice della complessiva felicità nazionale. E’ cresciuta la dimensione reale e la coscienza dell’ insostenibile rapporto fra il Nord e il Sud del pianeta, un rapporto che, così come sta oggi, non può durare. Il rapporto attuale fra popolazione e risorse nelle diverse aree del pianeta non è sostenibile: il fenomeno delle immigrazioni sarà sempre più massiccio senza interventi che vadano alle radici del problema. Su questi temi pesa l’eredità di una lunga storia dei processi di colonizzazione e decolonizzazione che chiamano direttamente in causa l’Europa. Il fattore religioso è riemerso sulla scena mondiale in primo piano, ma ha assunto anche, specie nell’Islam, forme fondamentaliste che rappresentano una sfida imprevedibile e inquietante alla democrazia e ai valori liberali: proprio a questi valori il fondamentalismo islamico attribuisce la responsabilità della crisi del tessuto etico religioso della società occidentale verso la quale concentra perciò la sua polemica e il suo attacco. Guai ai corti circuiti e alle semplificazioni culturali, ma il fatto che il secolo si sia aperto con la tragedia dell’11 settembre non è certo casuale. La risposta non può essere la rinuncia alla libertà religiosa e alla laicità dello Stato ma dobbiamo forse ripensare la laicità in termini che non escludano anzi valorizzino l’apporto delle esperienze religiose alla formazione del tessuto etico della società. Se non vogliamo che del fattore religioso, del cristianesimo, si impadroniscano i teocon, con l’effetto di favorire uno scontro di civiltà in cui di fatto i valori di libertà cui essi si appellano, quando parlano di Occidente, sarebbero radicalmente compromessi. Il terrorismo ha avuto una sua prima vittoria nel porre in crisi, con il Patriot Act i principi stessi dell’habeas corpus, fondamento del liberalismo. Dahrendorf segnalava pochi giorni fa come uno scandalo la “nuova teoria” enunciata dal primo ministro inglese Blair, secondo cui la sicurezza sarebbe la prima delle libertà, una sicurezza della quale lo Stato definisce le condizioni anche limitando la libertà dei cittadini. Così al senso di dipendenza e di frustrazione prodotto da un determinismo frutto del sistema economico e dalla rincorsa tecnologica si aggiunge un secondo motivo di insicurezza tutto interno alle responsabilità politiche e religiose: la crisi nel rapporto tra i popoli e le religioni. La libertà dal determinismo, la liberazione dalla paura e la riscoperta della speranza come spazio vitale necessario alle nuove generazioni non sono certo obiettivi facili, alla portata soltanto di un partito politico, sono tuttavia elemento essenziale di una cultura che un partito democratico deve coltivare. Tutto si inquadra in una visione europeistica e internazionalistica che non deve essere un punto del programma del nuovo partito ma una sua connotazione essenziale. Ma l’incertezza che assilla le nuove generazioni ha altri aspetti che sono parte essenziale di una nuova domanda di politica. Si pensi alla possibilità e alla stabilità del lavoro, alle garanzie per la vecchiaia e per la malattia, insomma a quello che il welfare aveva conquistato e la globalizzazione ha messo in discussione. Qui il rischio è quello di una difesa quantitativa che si risolva in un progressivo arretramento senza un salto di qualità. Quello che l’individuo della società preindustriale trovava nella grande famiglia patriarcale di un tempo e che l’individuo isolato e la famiglia nucleare della società industriale ha cercato e trovato, almeno in parte, nello Stato sociale, deve essere ricuperato sul terreno di un tessuto sociale nuovo che alla solitudine dell’uomo moderno risponda con un tessuto libero di amicizie. L’amicizia contro la solitudine, l’amicizia come l’etimologia suggerisce che nasce dall’amore e non l’amicizia politica anticamera di corruzione. La riforma del Welfare in altre parole non è questione di quantità o di tagli, ma di riconversione qualitativa nel senso di un coinvolgimento di tutto il tessuto sociale su valori di convivenza. solidarietà, amicizia appunto. Non si tratta solo di vecchiaia o di malattia: si tratta anche di socializzazione di giovani e giovanissimi. Si pensi ai bambini e ai ragazzi la cui socializzazione è affidata oggi alla vita di banda nelle strade, a rumorose sale da gioco, alla pratica non dello sport ma del fanatismo sportivo, alla televisione. Perché non pensare ad una funzione più ampia della scuola e ad una valorizzazione, con opportuni incentivi, di tutte le iniziative esistenti nel quadro di una applicazione larga, non gelosa, del principio di sussidiarietà. Ecco: crisi di identità e questione democratica, determinismo e libertà, paura e speranza di futuro, solitudine e amicizia, sono queste alcune delle dicotomie sulle quali un partito nuovo dovrebbe costruire la sua identità e il suo progetto. I miei sono solo esempi: il discorso avrebbe bisogno di ben altri sviluppi e ben altre competenze. Ma questi accenni sono sufficienti per comprendere che un partito che si muova in un simile orizzonte culturale esige una struttura del tutto nuova, tutta da inventare, una nuova forma partito. Non si tratta di mettere insieme pezzi di classi dirigente portatori di tradizioni culturali di partito, spesso ossificate, ma pezzi di popolo, milioni di cittadini personalmente coinvolti ciascuno con la sua storia, la sua cultura, la sua sensibilità. L’apporto delle diverse culture e tradizioni democratiche è essenziale purché non si scambi questa feconda integrazione solo con un incontro e una intesa dei gruppi dirigenti dei partiti. Le sfide per la democrazia oggi riguardano la possibilità di restituire fiducia nella capacità costruttiva della politica, nell’utopia democratica, di restituire a quest’ultima nuovo vigore. V. Ripeto: i gruppi dirigenti dei partiti e i partiti si incontrino e diano vita per quanto possibile a un nuovo soggetto unitario ma avvertano il rischio e la tremenda responsabilità delle parole: il rischio che le speranze cresciute in questi anni, che negli ultimi mesi i partiti stessi hanno acceso e diffuso e che hanno dato vita ad un significativo protagonismo femminile, ad una mobilitazione di popolo che ha coinvolto milioni di donne, di uomini e di giovani diventino nuove delusioni. Non si può ripetere all’infinito che il paese è maturo per un partito democratico, che c’è una diffusa domanda di base, senza compiere poi atti conseguenti, seri ed efficaci. I partiti facciano i passi oggi possibili, ma lascino aperta una grande finestra verso il futuro. E teniamo noi tutti, cittadini della Repubblica. viva dentro e fuori i partiti una prospettiva più ampia, un disegno più ambizioso, una tensione ideale che superi le singole appartenenze, che non guardi più alle componenti come realtà separate e non comunicanti, ma piuttosto esalti i valori comuni. alori comuni da cercare proprio nella nostra Costituzione. Si discusse alla Costituente se la nuova Costituzione dovesse avere un presupposto ideologico e un punto di incontro fu trovato nell’idea della dignità della persona umana. Era una idea di matrice cristiana che laicamente declinata ispirò largamente il testo costituzionale. Mi chiedo se quella intuizione che ha fondato non solo tutte le tradizionali libertà ma il principio di uguaglianza e il rifiuto della guerra non possa diventare principio animatore della vita associata, non possa ispirare una laicità e una libertà di coscienza e di religione che non neghino, anzi valorizzano, l’apporto delle esperienze religiose alla vita sociale, non possa animare non solo le iniziative statali di welfare, ma uno spirito di solidarietà (di amicizia) in tutto il tessuto sociale, non possa sollecitare la ricerca di nuovi modelli di sviluppo. Il partito democratico può trovare in questo patrimonio di valori la sua stella polare.
Orvieto, 6 ottobre 2006






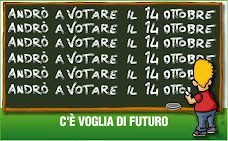


Nessun commento:
Posta un commento